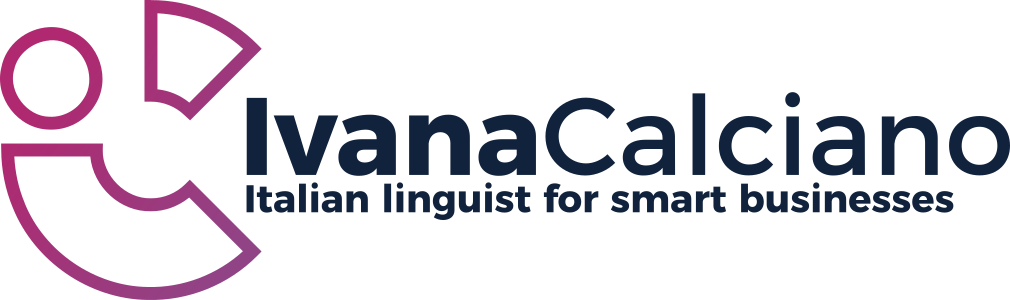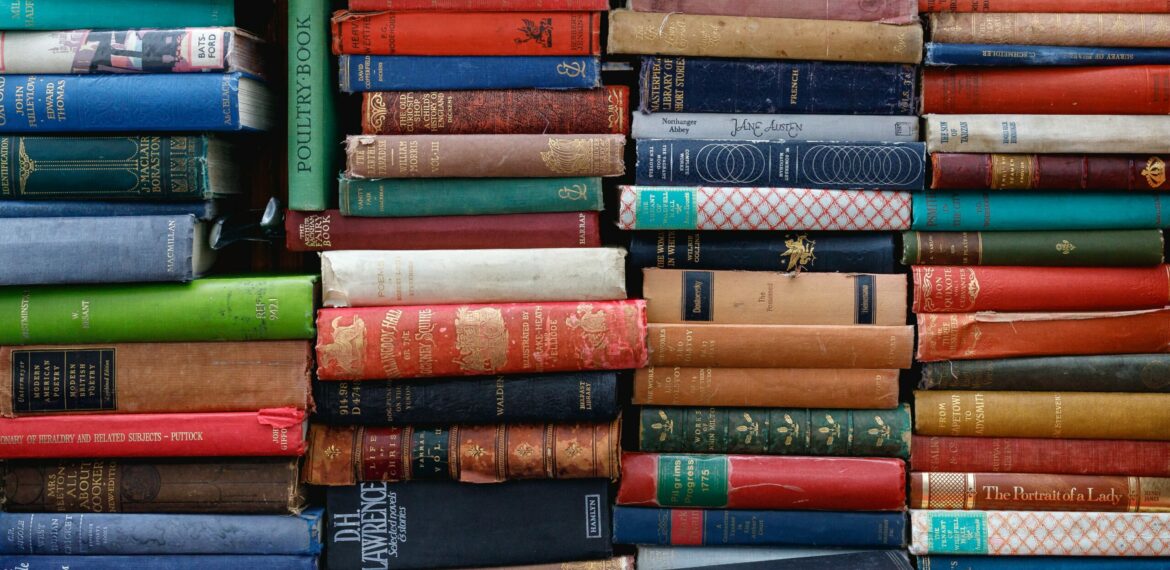Esportazione culturale: chi “ha” più diritto alla parola?
“Gli fu fornito il Manuale linguistico per l’Africa Orientale, uno snello libretto adatto da tenere in tasca, approvato dal ministero della Guerra. In copertina, accanto alla sagoma del Corno d’Africa, era disegnato in azzurro il busto di un milite sorridente col fucile imbracciato. Era un dizionario dall’italiano alle quattro lingue più parlate nelle colonie: galla, amarico, arabo e tigrino. Non conteneva il dizionario speculare, quello verso l’italiano. Per il ministero, evidentemente, agli italiani in Etiopia era necessario esprimersi ma non capire. Con mirabile sintesi, il manualetto riassumeva sia il diritto alla parola dei colonizzatori, che il dovere dei colonizzati di ascoltare – e obbedire.”
Francesca Melandri, Sangue giusto
La traduzione è sempre un atto politico. Riconoscere la natura intrinsecamene politica dell’atto traduttivo è ciò che anni fa mi aveva attratto verso la teoria della traduzione e permesso di capire come essa non fosse soltanto una semplice trasposizione oggettiva di parole tra lingue diverse. Su questa peculiarità non riflettevo da tempo, finché non me lo ha casualmente ricordato questo passaggio dello strepitoso romanzo di Francesca Melandri Sangue giusto. In che modo? Il passo citato ben testimonia una delle modalità in cui il potere della lingua e della traduzione può essere esercitato. Tradurre vuol dire dare accesso a un qualcosa che altrimenti non si potrebbe comprendere. Decidere cosa tradurre (e cosa non tradurre), come tradurre, per chi e quando farlo determina il tipo di messaggio cui un certo gruppo di persone potrà accedere (o non potrà accedere) in un determinato momento a un determinato fine. L’immagine riproposta dalla citazione è in tal senso esemplare: i fascisti colonizzatori dell’Abissinia vengono dotati di un manuale linguistico per tradurre i propri ordini ai colonizzati ma non di uno con cui poter tradurre le loro risposte e ascoltare le loro esigenze.
Se in casi “estremi”, come possono essere state le occupazioni coloniali, queste dinamiche si manifestano alla luce del giorno o sono addirittura imposte per legge, in altre circostanze storiche queste possono riproporsi in maniera analoga, sebbene più velata. Si potrebbe, per esempio, affermare che una delle chiavi del successo della politica imperialista americana risieda nella diffusione su scala globale della propria cultura attraverso la traduzione. Si pensi in modo particolare alla TV, alla pubblicità ma soprattutto alle produzioni hollywoodiane, che hanno contribuito a diffondere nel mondo l’immagine di un certo stile di vita e ad alimentare negli individui la bramosia di farlo proprio. Non ci sono volute violente imposizioni dall’alto perché ciò accadesse. È bastata l’esportazione di quel materiale culturale – essa sì, forse imposta – coadiuvata dalla traduzione, senza la quale non lo si sarebbe potuto comprendere né farlo parlare dritto ai desideri e alle emozioni delle persone.
Volendo restringere il campo di osservazione a un settore, la letteratura, in cui la traduzione può essere più facilmente rintracciata in quanto atto di scrittura, si osserva come i flussi di traduzione siano sempre stati notevolmente più intensi dal “centro” verso le “periferie”, termini qui intesi in senso metaforico per designare la cultura dominante anglofona da una parte e le culture e lingue minori dall’altra. Nel mercato editoriale, questo fenomeno si avverte come difficoltà degli autori a imporsi sul mercato anglo-americano o sul mercato internazionale, mercato che spesso richiede comunque il passaggio attraverso la lingua inglese. Literaturkritik cita come esempio Elena Ferrante, che ha raggiunto i lettori tedeschi non direttamente dall’Italia, ma passando per gli Stati Uniti: finché il New Yorker non ne ha recensito i romanzi, li si è letti in inglese; solo dopo è arrivata la traduzione in tedesco.
Nel mercato editoriale di lingua inglese, notoriamente soltanto il 3% di tutti i libri pubblicati è tradotto da altre lingue. Sebbene negli ultimissimi anni questa percentuale sia andata crescendo, toccando per esempio nel 2018 una punta del 5,5% nel Regno Unito, il dato resta comunque basso se paragonato, ad esempio, a quello del mercato editoriale di lingua tedesca: qui il 14% circa delle novità editoriali annuali sono tradotte, in prevalenza dall’inglese (oltre il 60%) (Fonte: uepo.de). In altri Paesi le percentuali di opere di autori stranieri pubblicate in traduzione sono ancora più alte: in Italia nel 2020 erano il 17% (con tendenza decennale al ribasso) di cui anche qui oltre il 60% dall’inglese; percentuali analoghe si registrano in Francia. Nei Paesi più piccoli il numero di traduzioni sale ulteriormente e quello delle traduzioni dall’inglese può raggiungere addirittura l’80% del totale dei titoli tradotti.
Se prendessimo in esame le produzioni musicali o cinematografiche, si delineerebbe con molta probabilità un quadro analogo, se non ancora più desolante. Del resto, quante band e quanti film non anglofoni riescono nell’impresa di raggiungere un’audience globale?
Possiamo dunque concludere che, in termini di traduzione o esportazione culturale, il “centro” parla alla “periferia”, ma non la ascolta o la ascolta poco. E anche quando lo fa, ne detta i termini e le condizioni. È noto che il mercato anglofono tenda ad “addomesticare” – per utilizzare un noto termine del teorico della traduzione Lawrence Venuti – ciò che proviene da fuori, ovvero ad appianare tutti i possibili elementi stranianti riconducendoli a un testo e contesto già noti al pubblico di arrivo. Prediligendo così la comprensione, la chiarezza, la familiarità, viene eliminata di fatto anche l’alterità, la differenza. Alcuni coreani hanno ad esempio criticato i traduttori dei sottotitoli inglesi della serie Squid Game per aver modificato a tal punto i dialoghi che, praticamente, “se non capisci il coreano, non stai guardando la stessa serie”. Ciò che sarebbe andata persa, affermano, è l’ideologia stessa che lo sceneggiatore intendeva comunicare agli spettatori.
La dominanza dei flussi di esportazione culturale dal “centro” verso le “periferie” – lo sottolineiamo – non ha nessuna giustificazione qualitativa: non c’è nessuna ragione di credere che tutta la produzione culturale anglofona sia superiore a quella di altre culture e abbia quindi più motivo di essere tradotta e distribuita altrove. Questa circostanza è esclusiva conseguenza di scelte e dinamiche di ordine politico. Se per i membri delle culture dominate ciò si riflette in una difficoltà a far emergere la propria voce oltre i confini “nazionali”, per i membri delle culture dominanti ciò produce una sorta di invisibilità verso la pluralità culturale e linguistica e, di conseguenza, una visione più omogenea del mondo. Ne deriva anche una quasi rassicurante pretesa che, ovunque vada, un parlante inglese possa fare le cose nella propria lingua. Potrà chiedere, ma non necessariamente ascoltare. Non avendo comprensione della differenza, non potrà riconoscerla nella sua dignità di esistere.